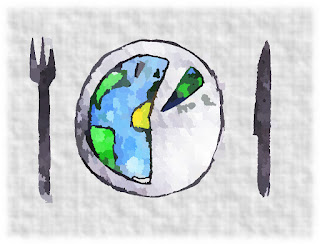"L'Università è sull'orlo del baratro,
questa riforma è un passo avanti."
Questo che segue è un commento di uno studente universitario (il sottoscritto) che ormai si avvicina ad aggiungere "ex" davanti a "studente universitario", che deve ringraziare l'università per avergli regalato i migliori anni della propria vita - finora -, insieme ad una pessima opinione sull'università stessa.
Chiariamoci: non rimpiango (quasi) nessuna delle scelte che ho fatto, né quella di scegliere l'università, né quella di passare da Chimica a Scienze Ambientali, né quella di continuare, nonostante tutto, anche con la specialistica (che, dato che non andava più di moda, adesso si chiama magistrale).
Sono quattro anni e un po' che mi hanno dato moltissimo, un po' (un pochino, a dir la verità) come nuove conoscenze scientifiche, tanto come apertura mentale, visione d'insieme sul mondo, l'uomo e le due cose insieme, e tantissimo con le persone che ho conosciuto.
Ma sono sicuro che l'università avrebbe avuto le potenzialità per fare molto, molto di più, e se non ci sarà un cambio di rotta, nei prossimi anni darà sempre meno a quelli che verranno dopo di noi.
La mia impressione è che in università, da un po' di tempo (un bel po', forse) si navighi a vista, senza un minimo di programmazione, e per di più ognuno per la sua strada senza che ci sia un comando forte a dare la direzione. Aggiungeteci che ogni ministro dell'istruzione vuole fare la sua riforma che cambia tutte le carte in tavola, e immaginatevi tutte queste barchette che sono i corsi di laurea, sbattute quà e là dall'imprevedibile vento delle riforme, senza nulla a tenerle insieme.
Per fare un esempio, così è stata gestita la protesta dei ricercatori dall'Università di Parma: dopo che i ricercatori hanno ritirato la loro disponibilità a svolgere attività didattica non prevista dal contratto (ovvero, decine di insegnamenti che tenevano gratis per tenere in piedi la miriade di Corsi di Laurea che abbiamo), il Senato Accademico non ha preso particolari provvedimenti, demandando la questione alle facoltà; le facoltà idem (a parte Ingegneria che, tanta stima per aver avuto semplicemente del buon senso, ha avvisato gli studenti della situazione); i corsi di laurea (almeno il nostro) hanno preferito non prendere nessuna decisione e aspettare l'inizio dell'anno.
Risultato: l'anno è iniziato apparentemente senza anomalie (di 50 matricole, solo 2 conoscevano la situazione, e cioè che alcuni insegnamenti non avevano un docente), ma al momento dell'inizio delle lezioni, dato che in qualche modo gli insegnamenti previsti si dovevano fare, sono state fatte alla bell'e meglio delle pezze, avvalendosi di altri insegnamenti simili, spostando corsi al secondo semestre (cioè, rimandando un problema che ci troveremo ad affrontare adesso), e via dicendo. In conclusione, leggero - ma silenzioso e inesorabile, visto che questo è solo un esempio - peggioramento della qualità didattica per gli studenti, e nessuno o scarso aiuto a diffondere la conoscenza della protesta dei ricercatori.
E la possibilità, per l'università, di beccarsi delle (giuste) denunce da parte degli studenti che si sono iscritti ad un corso e hanno trovato degli insegnamenti diversi da quelli previsti dal manifesto degli studi.
Mea culpa, anche, dato che sono rappresentante degli studenti ed ero in consiglio quando si è discusso di questi temi. Ero - e sono - inesperto (due anni di mandato e nessuno che ti insegna è troppo poco per capire come funziona la quasi-democrazia universitaria), probabilmente avrei dovuto, almeno, dichiarare il mio voto in disaccordo sulle decisioni prese, ma ormai così è andata, ed è il momento della verifica.
Adesso ci troviamo con un'università che ancora non sa quanto sarà il Fondo di Finanziamento Ordinario (la maggiore entrata dell'università, erogata dal Ministero) per l'anno 2010; che sa che dovrà chiudere, probabilmente, cinque Corsi di Laurea, ma ancora non sappiamo quali, e con che criteri saranno scelti; una facoltà con troppi pochi professori per garantire tutti i corsi di laurea che ha, ma dalla quale non arrivano indicazioni chiare sulla direzione da prendere, i criteri in base ai quali scegliere cosa tenere e cosa tagliare (e pensare che ha un organo consultivo, il Comitato Paritetico per la Didattica, nel quale alla prima riunione è stato detto "sarebbe bello che ci dicessero cosa deve fare questo comitato"); e per finire corsi di laurea che in fin dei conti sono quelli che devono far funzionare la didattica, e senza indicazioni dai livelli superiori quello che possono fare è puntare a sopravvivere ai pensionamenti dei docenti e l'assenza di nuove assunzioni, pezzando il pezzabile.
Mancando totalmente la programmazione, si fanno giusto le modifiche necessarie ad aprire il corso per l'anno successivo (perché nessun Consiglio di Corso di Laurea, se non forse qualche caso illuminato o disperato, deciderà mai per la chiusura di sé stesso, anche quando ce ne sarebbe bisogno), senza chiedersi se potranno essere mantenute nel tempo o se dovranno essere nuovamente cambiate l'anno successivo.
Questa situazione, anno dopo anno, ha portato a corsi di laurea dalla complicata organizzazione didattica per contenere poco contenuto, spesso ripetuto in insegnamenti diversi, magari poco approfondito perché professori si vedono costretti, per riempire vuoti di docenza, ad insegnare materie che non sono quelle su cui sono specializzati. Ad esempio, alla nostra domanda su quale fosse il contenuto di un insegnamento dal nome vago, da approvare nel manifesto degli studi per l'anno successivo ci è stato risposto "Dobbiamo decidere, ancora non sappiamo quale sarà il programma".
Chiaro che in questa situazione di caos, i "baroni" se ne stanno comodi e indisturbati sulle loro poltrone a fare i loro interessi.
Perciò, sì, avrete ragione se direte che c'è bisogno di una riforma. D'accordissimo! Ma non questa.
Ammetto di non essere stato così virtuso da leggermi il testo in discussione al Parlamento, ma mi sono un po' informato, e tra quello che ho sentito ci sono cose che mi lasciano indifferente, altre decisamente schifato. In particolare, la modifica del Consiglio di Amministrazione che diminuisce i membri eletti a favore di quelli che possono essere nominati dal Rettore, anche tra privati esterni all'Università. Quindi, di fatto, l'apertura ai privati alla gestione dell'Università, anzi del bilancio, delle risorse e dei beni mobili e immobili delle Università.
Cosa c'è di male? Beh, si tratta della privatizzazione, per ora parziale, dell'Università.
A qualcuno probabilmente potrebbe piacere, a me no. Primo, perché, volontariamente o involontariamente, un'università finanziata o peggio controllata da privati, subirà inevitabilmente un condizionamento (vi immaginate un dipartimento di Scienze Ambientali finanziato dal'ILVA di Taranto, o una facoltà di Lettere controllata da Mediaset?). Secondo, perché essendo in Italia, i privati che entreranno in Consiglio di Amministrazione potrebbero avere ben altri interessi che un buon funzionamento dell'Università: citando l'esempio di un mio prof, perché mai, potrebbe obiettare un potente industiale edile, continuare a far lezione nell'antico e scomodo palazzo dell'università in centro? Vendiamolo, ve lo comprerò io, ed in cambio vi fornisco dei moderni prefabbricati fuori città...
Ma forse il Governo cadrà prima che sia approvata questa riforma, e allora se ne riparlerà più avanti.
Da parte mia, credo che si possa migliorare l'unviersità senza stravolgere di nuovo la sua organizzazione, semplicemente ritoccando alcuni aspetti, e dando chiare e precise direttive da tutti gli organi superiori ai livelli inferiori.
Le Università non vanno lasciate da sole! Sia perché hanno bisogno di indicazioni chiare su cui poter fare programmi, sia perché hanno bisogno di essere controllate.
Alcuni punti che proporrei:
Concentrare le Università. Sono troppe, in Italia, con troppi Corsi di Laurea. E' necessario, credo, che il Ministero e le Regioni prendano decisioni chiare su cosa si deve insegnare, e dove. Non vedrei di cattivo occhio anche delle Università regionali, se fatte bene. E' vero che più studenti si dovrebbero spostare: ma da una parte credo sia necessario un maggiore aiuto economico agli studenti meritevoli, anche per quanto riguarda vitto e alloggio, dall'altra parte penso che sia molto formativo anche il doversi trasferire in un'altra città, imparando ad essere autonomi (e su questo punto mi sento molto indietro rispetto ai miei compagni che non hanno l'università di fianco a casa). Per questo, però non basta tagliare e dire "strigatevela". Bisogna prendere delle decisioni motivate, dire "questo si tiene, questo no".
Potenziare di molto, e semplificare, gli aiuti economici agli studenti meritevoli, basandosi più sul merito e meno sul reddito. Comprendere in questo l'accesso alla casa e alla mensa (non come Parma dove mangiare in mensa costa più che mangiare al pub). Se questo significa, per mancanza di fondi, restringere il numero degli studenti che l'università può accogliere, non penso sia un dramma: per l'istruzione di tutti i cittadini ci sono le scuole superiori; l'università deve essere, secondo me, un luogo dove chi si impegna possa avere una formazione davvero di alto livello senza dover pesare sulla famiglia, mentre chi non si impegna credo sia meglio vada a lavorare.
Aumentare parecchio i fondi per la ricerca universitaria, per i laboratori, le escursioni didattiche e le attività integrative, che non siano solo degli "assaggi" di laboratorio o peggio lezioni dal nome "laboratorio di ...", ma vere occasioni in cui gli studenti possano imparare a lavorare in luoghi dove si fa vera ricerca. E in questo senso si può già ottenere qualcosa con il primo punto, concentrando in pochi centri i fondi oggi troppo dispersi. Certo secondo me un imput extra sulla ricerca non farebbe male all'Italia...
Aumentare parecchio anche il controllo sulle Università, richiedere che sia svolto effettivamente quanto dichiarato, e rispettate le richieste del Ministero. Chiedere che i fondi siano spesi in modo efficace e trasparente. Migliorare i meccanismi di valutazione delle Università, e dei singoli professori. Ad esempio, non mi sembra logico valutare le Università su quanti studenti immatricolano, o quanti studenti vengono "persi per strada": mi sembra più logico valutarle in base a quanti si laureano, e con quale preparazione (preparazione non valutata con il voto di laurea, ovviamente...). E dalla ricerca che viene fatta, anche.
Favorire e incentivare la partecipazione degli studenti alla vita democratica dell'Università. Aumentare, anche, la loro voce in capitolo negli organi universitari, dove adesso spesso sono considerati (anche da loro stessi) come "ospiti" non sempre troppo graditi. L'università è di tutti i cittadini, e in particolare degli studenti, cavolo, non solo dei professori che dovrebbero essere lì per svolgere un servizio!
Ok, sono stato un po' troppo critico e cattivo, mi sa.
Non è tutto così nero, è solo che avevo un po' di spine sotto la lingua da togliermi.
L'università, in sé, ha un enorme potenziale che va salvaguardato. E', o dovrebbe essere, il luogo dove tutti, indipendentemente dall'origine e dalla situazione economica, possono tirar fuori il loro valore e prepararsi a diventare pilastri importanti, forse fondamentali della società.
E per fortuna c'è, nonostante tutti i difetti, questa possibilità anche nell'università di oggi.
Ci sono migliaia di studenti di ogni parte d'Italia, anzi del mondo, che si incontrano, si conoscono, studiano insieme, insieme si scambiano idee e sogni sul mondo di domani. Sarà retorico, però penso che se l'Università non ci fosse, non ci sarebbe un altro luogo capace di fare la stessa cosa.
Non ci sono solo baroni, ci sono anche professori, ricercatori, dottorandi appassionati e che sanno appassionare, sanno far riflettere. Sanno anche indicare la strada giusta, a volte, e proprio io devo ringraziare davvero alcuni professori per questo.
E' una ricchezza enorme per il mondo, che qui in Italia stiamo trascurando troppo da parecchio tempo.
Adesso concludo: voglio solo aggiungere che, secondo me, è giusto e doveroso che gli studenti (e non solo loro) protestino. E non lo dico solo perché non condivido questa riforma, ma anche e soprattutto perché una società viva, di gente che pensa e alla quale sta a cuore il bene di tutti, è anche una società dove si protesta: la protesta è anche quella un luogo di confronto, un modo per svegliarsi e svegliare gli altri dal sonno delle coscienze, di sputar fuori i problemi sepolti per chiedere che vengano conosciuti e discussi.
E' un modo di far sentire che siamo vivi, che non ci limitiamo a sopravvivere nella normalità, ma vogliamo cambiare il mondo!